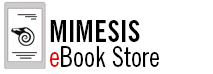Perché, nelle morfologie del Moderno, il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas ha individuato nel diritto sia il medium formale, procedurale e istituzionale dell’integrazione sociale sia uno strumento di emancipazione dell’umano nel conflitto ontologico-politico e sociale che lo conforma? Per Habermas, nei mondi sociali degli interessi, dell’agire strategico, dei rapporti di dominio pervasi dai media funzionali del denaro e del potere, dall’antropologia degli schermi digitali e dell’intelligenza artificiale, attraverso il diritto, cercando di connettere nella logica discorsiva dell’intesa i sistemi al mondo della vita, è possibile coniugare la coesione sociale con il particolarismo delle identità individuali e di gruppo, nel quadro di uno “Stato democratico di diritto” che includa i soggetti senza attentare alle loro diversità. Habermas legge il diritto e il sistema giuridico come dimensioni dell’interazione sociale nella difficile distinzione/mediazione tra discorso giuridico, morale e politico, tra sociologia del diritto e filosofia della giustizia. Il diritto, nella sua componente di “fatticità”, è capace di imporre il rispetto delle norme. Il problema è: come legittimarlo implicando la tutela della libertà e degli individui dopo la secolarizzazione della giustizia tra nuove forme oligarchiche di potere e incognite dei destini democratici nella cifra del presente? Con Soggetti di diritto, un’originale e completa monografia sul discorso filosofico-giuridico di Habermas, Antonio De Simone illumina il tratto habermasiano che ha “trasformato” la teoria critica della modernità, della intersoggettività, della ragione comunicativa e della normatività. Una lezione habermasiana, quella di De Simone, necessaria per comprendere la dialettica normativa contemporanea entro e oltre il destino dell’Occidente, nel divenire del mondo.
Dettagli libro
-
Editore
-
Lingua
Italiano -
Data di pubblicazione
-
Collana
Sull'autore
Antonio De Simone
Antonio De Simone, filosofo e saggista, è professore di Storia della filosofia e Filosofia della cultura all’Università di Urbino. Nel 2013-14, con l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ha ottenuto l’idoneità a professore ordinario di Storia della filosofia e di Filosofia politica. Con un peculiare stile intellettuale si è occupato del pensiero filosofico, politico, etico-giuridico, ermeneutico, estetico e sociologico moderno e contemporaneo; ha analizzato, tra l’altro, il rapporto tra soggetto, conflitto e potere nelle metamorfosi della modernità a partire da Machiavelli; ha inoltre contribuito alla ricezione nazionale e internazionale dell’opera di Georg Simmel e di Jürgen Habermas. È autore di oltre una quarantina di volumi; tra i recenti: L’inquieto vincolo dell’umano (2010); Passaggio per Francoforte (2010); Dislocazioni del politico (2011²); Conflitto e socialità (2011); Il soggetto e la sovranità (2012); Alchimia del segno (2013); Machiavelli (2013); L’arte del conflitto (2014, 2016²); L’Io reciproco (2016); Intervista a Machiavelli (et. al., 2017³, Premio Letterario Nazionale “U. Fraccacreta”, 2018); Il ponte sul grande abisso (2017²); La via dell’anima (2017); Dismisure (2017); Il primo Habermas (2017²); Destino moderno. Jürgen Habermas. Il pensiero e la critica (2018); Post res perditas. Discorsi su Machiavelli. Lezioni Urbinati (2019). Ha curato le raccolte di saggi Leggere Simmel (2004); Identità, spazio e vita quotidiana (2005); La vita che c’è (et. al., 2006, 2 voll.); Diritto, giustizia e logiche del dominio (2007); Paradigmi e fatti normativi (2008); Per Habermas (et. al., 2009); Leggere Canetti (et. al., 2011). Ha ricevuto premi e riconoscimenti di prestigio per la sua attività scientifica. Collabora con riviste nazionali e internazionali. È direttore di Collane editoriali ed è Socio Ordinario dell’Accademia Raffaello di Urbino. È stato relatore al Festivalfilosofia di Modena.